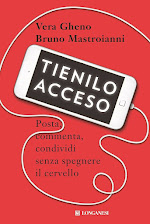Nel contesto digitale, l’errore non è più solo un incidente, ma diventa un fenomeno di rete capace di influire potentemente nelle relazioni. Non importa che si tratti di un creator di grande visibilità o di un utente qualsiasi che invia il messaggio sbagliato: il guaio, amplificato dalla sua digitalizzazione nelle piattaforme di comunicazione, si trasforma in crisi di reputazione. Questa condizione, che potremmo definire di “fallibilità aumentata” (QUI un articolo in cui approfondisco il tema), impone un ripensamento profondo della concezione dell’errore.
La prevenzione non basta
La tecnologia ha aumentato le possibilità di comunicazione, ma ha anche moltiplicato le occasioni in cui compiere passi falsi. L’invio impulsivo e l’eccessiva fiducia nella correzione automatica producono esiti a volte comici, altre volte gravi. Per chiunque invii qualcosa servendosi delle tecnologie digitali diventa cruciale rimettere costantemente in primo piano la fase di rilettura e di revisione dei contenuti. Questa azione viene spesso trascurata soprattutto quando si opera su certe piattaforme che, per il loro funzionamento, possono trasmettere all’umano un senso rapidità e imporre una certa fretta psicologica nel momento di inviare.
Allo stesso tempo, le soluzioni basate esclusivamente sulla prevenzione (revisioni, formazione, linee guida sull’uso dei social, regolamenti interni) seppur indispensabili, non risolvono la radice del problema: l’errore è connaturato all’esperienza umana e non può essere eliminato. Serve allora guardare all’errore nella sua versione potenziata dalle tecnologie, per poterlo gestire al meglio.
Allo stesso tempo, le soluzioni basate esclusivamente sulla prevenzione (revisioni, formazione, linee guida sull’uso dei social, regolamenti interni) seppur indispensabili, non risolvono la radice del problema: l’errore è connaturato all’esperienza umana e non può essere eliminato. Serve allora guardare all’errore nella sua versione potenziata dalle tecnologie, per poterlo gestire al meglio.
La fallibilità aumentata dal digitale
L’ecosistema digitale rende qualsiasi atto di comunicazione persistente, riproducibile, pubblico o semi-pubblico (pensiamo alla pratica dello screenshot), ma anche in qualche modo decontestualizzato: è frequente, infatti, che ciò che era pensato per un certo uditorio finisca sotto gli occhi di chi non ci si era prefigurati di raggiungere. Anche i sistemi di cancellazione e revoca delle pubblicazioni presentando diversi limiti. Pensiamo a una piattaforma di messaggistica come WhatsApp che consente di eliminare o modificare i testi dopo l’invio. È un rimedio solo parziale: l’etichetta “messaggio eliminato” o quella “modificato” può stimolare ulteriore attenzione sull’errore compiuto.
Se in questo discorso includiamo le tecnologie di Intelligenza Artificiale, l’errore diventa ancora più complesso: bias algoritmici, allucinazioni, interpretazioni errate di testi, traduzioni imprecise. Anche qui l’eccessivo affidarsi al sistema digitale, spesso per comodità e per accelerare i processi, può indebolire la necessaria vigilanza umana che dovrebbe accompagnare ogni atto di comunicazione.
Il recupero dall'errore
Di fronte a questa situazione occorre adottare un approccio a doppia valenza: prevenire sì, con policy adeguate e buone virtù di revisione, ma soprattutto occorre ripartire dal valore della gestione dell’errore, per saper reagire, essere in grado di comunicare in modo adeguato, riparare e ristabilire fiducia.
In un’organizzazione umana efficace deve oggi più che mai maturare la consapevolezza che l’errore ci sarà, il punto è che, se ben gestito, può diventare un’opportunità di apprendimento e rafforzamento della credibilità. Occorre coltivare una rinnovata “cultura dell’errore” che stimoli all’apertura mentale e all’accettazione dell’adattamento continuo come dimensione ineliminabile delle relazioni umane. Mettersi sempre di più al riparo da ideali di assenza dell’errore (impossibili da realizzare) e puntare sulle qualità relazionali e sociali che alimentano la capacità di recupero.
Recuperando si impara
La valorizzazione dell’errore come risorsa strategica è da sempre una buona pratica per le organizzazioni umane. Per governare il cambiamento digitale diventa ancora più importante: un trampolino per innovare processi, affinare competenze relazionali e comunicative. L’imperfezione umana amplificata dal digitale richiede di rivedere gli atti di comunicazione anche alla luce di un continuo ciclo di potenziale caduta, apprendimento e riparazione, dove quest’ultima diventa il valore centrale.
Insomma, il classico “sbagliando si impara”, in un sistema di “fallibilità aumentata”, dovrebbe evolvere in un più articolato: “sbagliando potenziati, si impara se si riesce a comunicare efficacemente la riparazione”.
L’ecosistema digitale rende qualsiasi atto di comunicazione persistente, riproducibile, pubblico o semi-pubblico (pensiamo alla pratica dello screenshot), ma anche in qualche modo decontestualizzato: è frequente, infatti, che ciò che era pensato per un certo uditorio finisca sotto gli occhi di chi non ci si era prefigurati di raggiungere. Anche i sistemi di cancellazione e revoca delle pubblicazioni presentando diversi limiti. Pensiamo a una piattaforma di messaggistica come WhatsApp che consente di eliminare o modificare i testi dopo l’invio. È un rimedio solo parziale: l’etichetta “messaggio eliminato” o quella “modificato” può stimolare ulteriore attenzione sull’errore compiuto.
Se in questo discorso includiamo le tecnologie di Intelligenza Artificiale, l’errore diventa ancora più complesso: bias algoritmici, allucinazioni, interpretazioni errate di testi, traduzioni imprecise. Anche qui l’eccessivo affidarsi al sistema digitale, spesso per comodità e per accelerare i processi, può indebolire la necessaria vigilanza umana che dovrebbe accompagnare ogni atto di comunicazione.
Il recupero dall'errore
Di fronte a questa situazione occorre adottare un approccio a doppia valenza: prevenire sì, con policy adeguate e buone virtù di revisione, ma soprattutto occorre ripartire dal valore della gestione dell’errore, per saper reagire, essere in grado di comunicare in modo adeguato, riparare e ristabilire fiducia.
In un’organizzazione umana efficace deve oggi più che mai maturare la consapevolezza che l’errore ci sarà, il punto è che, se ben gestito, può diventare un’opportunità di apprendimento e rafforzamento della credibilità. Occorre coltivare una rinnovata “cultura dell’errore” che stimoli all’apertura mentale e all’accettazione dell’adattamento continuo come dimensione ineliminabile delle relazioni umane. Mettersi sempre di più al riparo da ideali di assenza dell’errore (impossibili da realizzare) e puntare sulle qualità relazionali e sociali che alimentano la capacità di recupero.
Recuperando si impara
La valorizzazione dell’errore come risorsa strategica è da sempre una buona pratica per le organizzazioni umane. Per governare il cambiamento digitale diventa ancora più importante: un trampolino per innovare processi, affinare competenze relazionali e comunicative. L’imperfezione umana amplificata dal digitale richiede di rivedere gli atti di comunicazione anche alla luce di un continuo ciclo di potenziale caduta, apprendimento e riparazione, dove quest’ultima diventa il valore centrale.
Insomma, il classico “sbagliando si impara”, in un sistema di “fallibilità aumentata”, dovrebbe evolvere in un più articolato: “sbagliando potenziati, si impara se si riesce a comunicare efficacemente la riparazione”.