Esiste un sogno recondito che ognuno di noi ha ogni volta che affronta una discussione, ossia portare l’altro a dire: “hai ragione tu! Ho cambiato idea”. È il sogno che la controparte si arrenda, cambi opinione, torni sui suoi passi e ammetta di aver perso la discussione. È l'illusione che la disputa finisca con un vincitore netto e uno sconfitto altrettanto riconoscibile.
Questa fantasticheria del “c’ho ragione io!” (romanesco voluto) non solo non si avvera, ma è uno degli atteggiamenti che contribuiscono al fallimento nelle discussioni. A ben vedere, infatti, questa aspettativa proviene da una precisa immagine che abbiamo del dibattito: discutere è per noi come battersi, come fare una lotta. E la battaglia, si sa, deve avere vincitori e vinti.
Dal duello al duetto
Ma è davvero la battaglia la raffigurazione che descrive meglio la situazione in cui ci troviamo quando stiamo discutendo? Adelino Cattani sostiene che quella della battaglia non è né l’unica immagine né la migliore per rappresentare la discussione. Infatti, ne propone una diversa: passare dal duello al duetto.
Secondo questa immagine discutiamo non per stabilire un vincitore e un vinto, ma per capire meglio qualcosa assieme attraverso le opinioni differenti. Mentre l’immagine della battaglia, fateci caso, si concentra soprattutto sui contendenti e su quanto riescano a far emergere le loro posizioni, quella del duetto tiene presente il pensiero che emerge.
Quelli che osservano senza intervenire
Un altro fattore da tener presente è il contesto: è facile che un duello porti a concentrarsi su ciò che A sta dicendo contro B e viceversa, dimenticandosi di tutti gli altri interlocutori coinvolti. Una discussione, specialmente se avviene sui social o su una piattaforma digitale (un gruppo di WhatsApp, uno scambio di mail in cc) ha anche una schiera di lettori, magari silenziosi, che assistono. La maggiore o minore riuscita del confronto è la risultano non solo di quanto A ha prevaricato su B, ma soprattutto di quanto le mosse di A o di B hanno attivato il pensiero di C1, C2, C3, CX (il pubblico che assiste).
Tenere in considerazione questa complessità di relazioni è fondamentale per capire che l’esito di una discussione non è così semplice come una vittoria o una sconfitta di uno sull’altro. Dalla metafora del duello o del duetto dipende qualcosa di fondamentale: muta il valore che si dà allo scambio e di conseguenza il giudizio su cosa sia una discussione buona e soddisfacente.
Il piccione idiota è più raro di quello che sembra
Tale prospettiva è fondamentale per decidere quando sia il momento di interrompere una discussione e capire fino a che punto sia accettabile discutere. Una questione che diventa sempre più urgente in un’epoca di smartphone e social in cui viviamo incontrando discussioni in ogni momento. Scegliere quali affrontare e quali meno, è fondamentale per la sostenibilità della nostra vita connessa.
Il meme che gira in rete usato come copertina di questo testo, viene spesso usato come ispirazione per decidere in quali casi discutere o meno: “Discutere con un idiota è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo, ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui”.
Se da una parte questa immagine in modo ironico dipinge bene l’inutilità di certe discussioni, dall’altra è abbastanza altezzosa e sprezzante. Applicando alla lettera la “lezione del piccione” si dovrebbe praticamente rinunciare a qualsiasi confronto in nome dell’inadeguatezza degli interlocutori. Il punto è che le discussioni non sono partire a scacchi, e le persone non sono né idioti, né tantomeno piccioni. Se vogliamo avere a che fare con gli altri in modo sereno dovremmo rinunciare a questo riduttivo modo di intenderli.
La discussione ideale (che non esiste)
Allora come fare per capire quando discutere o meno? Partiamo dal concetto di discussione ideale. Ci aspettiamo che ci siano due ingredienti:
1. la presenza di una questione oggettiva formulata per essere discussa (con prove e ragioni a supporto)
2. che i partecipanti alla discussione abbiano lo scopo di raggiungere maggiore chiarezza su quella questione attraverso la discussione.
Abbiamo cioè due piani: quello di un argomento articolato (1), e quello degli scopi collaborativi degli interlocutori (2). Ottimo. Quando si realizza davvero una discussione così? Pochissime volte! Molto più spesso un argomento anche rilevante viene sollevato da qualcuno che non ha la minima intenzione di capire meglio, ma ha il solo scopo di dimostrare superiorità rispetto agli altri.
Si può avere anche la situazione opposta: un interlocutore con lo scopo genuino di contribuire che però apporta argomentazioni che sono soggettive, prive di ragioni e prove o addirittura inadeguate al tipo di questione.
Fin qui tutto bene, potremmo dire. Finché c'è almeno uno dei due ingredienti (argomentazione oggettiva o intenzione di collaborare) ben vengano anche le polarizzazioni, le discussioni in stallo, gli scontri. Anche se sgangherati, disordinati, scomposti, ecc. ancora a qualcosa servono. In un modo o nell'altro muoveranno il pensiero perché si parla di qualcosa (questione oggettiva) o si parla con qualcuno (intenzione di collaborare).
Riconoscere il piccione
Il problema è se non abbiamo nessuno dei due ingredienti. È l’altro che cerca di dimostrare la propria superiorità, affermare la sua posizione senza argomentare, oppure lo fa con lo scopo di disturbare insultando, perdendo in giro o aggredendo gratuitamente gli altri interlocutori.
Ecco, quando in una discussione si arriva a non avere più una questione oggettiva da trattare e non c’è nemmeno lo scopo minimo di contribuire, siamo di fronte al caso del “piccione della scacchiera”, in cui l’unico vero bene è evitare di aggravare il male che si potrebbe arrecare proseguendo nel discutere.
Quando fermarsi?
Come fare allora a capire quando è il momento di fermarsi? La domanda del limite della discussione, infatti, non riguarda tanto le situazioni in cui è evidente che non si va da nessuna parte (la situazione del piccione insomma) quanto piuttosto quell’enorme insieme di situazioni intermedie e più frequenti in cui la discussione ha degli elementi di bontà misti a elementi deragliati e viziati.
Bisogna fare un'opera di setaccio. Negli scambi che abbiamo ci sono segnali che rivelano che chi sta discutendo non vuole davvero ragionare, ma ha piuttosto un'identità da difendere. Cogliere questi segnali è cruciale per scartarli e vedere se c'è altro nelle parole che apporti una qualche argomentazione. Se, scartandoli tutti, non rimane proprio nulla, siamo nella situazione del piccione. Ed è meglio passare oltre.
Le espressioni belligeranti
Un primo gruppo sono le espressioni belligeranti. Forme espressive che hanno l’effetto di creare immediatamente scontro nella discussione:
1. Dissociazioni sintetiche: “no!”, “non è così!”, “falso!”, “non è vero!”; affermazioni di contrarietà non argomentate ma semplicemente dichiarate per dissociarsi.
2. Espressioni di indignazione e giudizi non supportati da ragioni: “non puoi dire così!”, “è vergognoso!”, “è indegno!”; affermazioni di supposta inadeguatezza del pensiero altrui senza la dimostrazione di tale inadeguatezza.
3. Argomenti ad hominem: il rivolgersi alle caratteristiche personali dell’interlocutore per usarle come dimostrazione della invalidità dei suoi ragionamenti. Esempio: “dici così perché sei giovane”.
4. Generalizzazioni: il rivolgersi alle caratteristiche di appartenenza a un gruppo, a una categoria, a una corrente, a una cultura dell’interlocutore per rifiutare i suoi argomenti. Esempio: “Voi giornalisti fate sempre così”.
Le pseudo-argomentazioni
Un secondo gruppo è costituito da pseudo-argomentazioni che sembrano sostenere qualcosa che in realtà non dimostrano. Sono manovre usate per dare forza alle proprie idee senza avere una reale consistenza argomentativa:
1. La petizione di principio: “ciò che è vero è vero!”; “cio che è giusto è giusto!”. Oppure “questa tua idea è inaccettabile perché falsa!”. Si deduce la conclusione dalla premessa, il principio dà valore a sé stesso in modo tautologico senza esporre le ragioni che lo supportano.
2. Il richiamo al ruolo: “studio queste cose da anni, ne so qualcosa”; “sono uno scienziato/giornalista/avvocato e le assicuro che…”; la posizione che si ricopre viene chiamata in causa per garantire la validità di ciò che si dice, ma di nuovo non si dimostra nulla né si apportano ragioni consitenti.
3. L’intervento dell’autorità: mettere in campo “la Costituzione”, “la dottrina”, “la scienza”, “la tradizione” e qualsiasi altra autorità per usarla come iniezione di forza nel proprio ragionamento.
4. Le procedure: “non è questo il luogo in cui discuterne”, “non posso spiegarmi qui al meglio”; appellarsi ai limiti del mezzo di discussione come impedimento alla discussione stessa.
5. Le emozioni: “quello che dici mi offende e quindi la finiamo qui!”; porre come barriera al confrontarsi uno stato emotivo negativo procurato dalle parole altrui.
Riconoscere i segnali
Non è una lista completa dei possibili segnali che mostrano l'assenza di una genuina volontà di discutere e della presenza di una reale argomentazione, ma considerarli ci può far aguzzare lo sguardo e le orecchie per capire ciò che nelle nostre parole non sta più dando un contributo al confronto. Allo stesso tempo, ignorando questi e concentrandoci su eventuali parti di contributo e argomentative, avremmo qualche chance di condurre uno scambio che a qualcosa (anche minima) porta. O perlomeno possa servire a chi assiste per riflettere sul tema.
Riconoscere questi segnali, e altri che ne potrebbero scaturire, può aiutarci a fare lo stesso lavoro su noi stessi. Se i nostri interventi sono particolarmente conditi da queste formule, siamo di fronte alla necessità di smettere di insistere e di compiere un atto di umiltà intellettuale: riflettere meglio sulla nostra convinzione, capire se davvero vogliamo discutere e riconsiderare se abbiamo prove e ragioni sufficienti.
Le discussioni sono belle perché imperfette
Non illudiamoci di avere discussioni perfette. Le discussioni sono per loro natura sporche e sgangherate. E va bene così. Ma in mezzo a questo fango, vanno cercate pepite d'oro di argomentazione, altrimenti finisce che perdiamo tempo a schieraci ora da una parte, ora dall'altra istintivamente (o peggio per spirito identitario), definendo l'altro un piccione-idiota quando sta solo ponendo male questioni che varrebbe la pena di discutere.




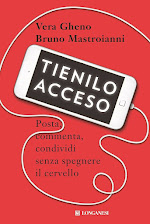



Social Plugin